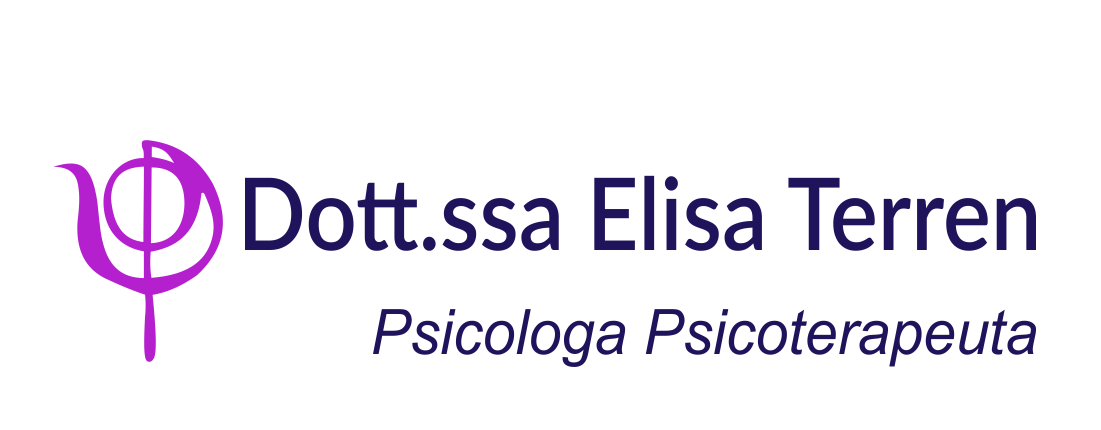Gradiva e cura psicoanalitica
…”L’immagine riproduceva, a un terzo delle dimensioni naturali, una completa figura femminile nell’atto di camminare: una donna ancor giovane, ma non più bambina […] Nel modo in cui la figura era riprodotta traspariva qualche cosa di umano e di comune (ma non nel senso deteriore), in certo modo qualcosa di moderno. […] Una figura slanciata e snella, la cui capigliatura lievemente ondulata era quasi completamente stretta da una sciarpa leggera. Non vi era alcuna civetteria nell’espressione del volto sottile; i suoi tratti raffinati esprimevano piuttosto una serena indifferenza per quanto si svolgeva intorno, l’occhio era tranquillamente rivolto davanti a sé, e lo sguardo non appariva turbato né da cose materiali né da complicazioni interiori. Così la giovane donna non colpiva tanto per una sua bellezza plastica; piuttosto possedeva una grazia naturale, semplice, virginale, che sembrava infondere vita all’immagine di pietra. Vi contribuiva notevolmente il movimento in cui la giovane donna era rappresentata. Col capo lievemente reclinato, tratteneva la veste assai ampia che scendeva dalle spalle alle caviglie, così che erano visibili i piedi nei sandali. Il piede sinistro era avanti, e il destro sul punto di seguirlo toccava appena con le punte delle dita il terreno, mentre la pianta e il calcagno si alzavano quasi verticalmente. Questo movimento dava una doppia impressione: soprattutto quella di una lieve agilità nel passo, ma insieme anche quella di una stabilità. Questo librarsi in volo, congiunto alla sicurezza dell’incedere, conferiva all’immagine la sua grazia specifica”.
Con questa scena si apre “Gradiva. Una fantasia pompeiana”, novella dello scrittore tedesco Wilhelm Jensen pubblicata nel 1903, che interessò così tanto Freud da scrivere su di essa un saggio, in cui sogni di sapore archeologico e ricerca psicoanalitica si legano e si spiegano vicendevolmente.
Nell’opera originale, che secondo il padre della psicoanalisi rappresenta l’esposizione poetica di un vero e proprio caso clinico, si ritrovano alcuni dei concetti fondamentali della sua teoria come quello di rimozione, delirio, inconscio, descritti in un linguaggio semplice e di piacevole lettura.
La novella narra la storia di un giovane archeologo tedesco, Norbert Hanold, che visitando un museo a Roma scopre un bassorilievo che lo colpisce a tal punto da spingerlo a procurarsi un calco in gesso dell’opera. Il protagonista sviluppa una vera e propria ossessione per tale immagine, alla quale da il nome di “Gradiva” (l’avanzante), ed inizia a fare alcune fantasie sulla sua origine fino a convincersi che la fanciulla sia una giovane ellenica vissuta nell’antica Pompei. Sulla scia di tale convinzione l’archeologo fa un sogno d’angoscia, in cui si ritrova proprio in tale città al momento dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ed incontra improvvisamente la Gradiva, assistendo impotente alla sua morte.
Dopo il sogno le fantasie si trasformano in veri e propri deliri che portano Norbert, spinto da un impulso irresistibile ma incomprensibile, ad intraprendere un viaggio in Italia fino a raggiungere proprio Pompei, dove incontra una donna che è sicuro essere la Gradiva, evidentemente tornata in vita.
In realtà è una sua coetanea, la sua più tenera compagna di giochi dell’infanzia, Zoe Bertgang, che nel tempo aveva completamente “dimenticato”, tanto da non averla più degnata di uno sguardo nemmeno quando la incontrava casualmente; nella ragazza, invece, con il passare degli anni il tenero affetto per l’amico si era trasformato in amore.
Sarà proprio l’amore che spingerà la ragazza ad entrare nel delirio del protagonista, assecondando le sue fantasie e fornendogli, con molta delicatezza, alcune informazioni che a poco a poco sgretoleranno la compattezza della sua costruzione delirante, riportandolo alla realtà attraverso un processo che Freud definisce un vero e proprio “trattamento psichico”.
Il padre della psicoanalisi, riferendosi al trattamento analitico, afferma: “negli ammalati che soffrono di disturbi analoghi al delirio di Hanold, l’inconscio, per la cui rimozione essi si sono ammalati, viene portato […] alla coscienza, proprio così come fa la Gradiva con i ricordi rimossi della loro relazione d’infanzia”.
Grazie agli interventi dell’amica, compiuti sempre con estrema delicatezza e rispetto, Norbert ricorda il profondo affetto per la vecchia compagna d’infanzia, ricorda che a lei apparteneva il particolare modo di camminare che tanto l’aveva colpito nel bassorilievo, comprende il motivo per cui aveva intrapreso il viaggio in Italia. Improvvisamente, attraverso un profondo insight, tutto diviene incredibilmente chiaro e comprensibile, persino il nome attribuito dal protagonista alla fanciulla del bassorilievo, che altro non è se non la traduzione in latino del cognome dell’amica (Bertgang), che in tedesco significa “colei che risplende nel camminare”.
Freud riscrive l’intera novella di Jensen alla luce dei concetti fondamentali della psicoanalisi e la arricchisce con particolari della vita psichica dei personaggi, che acquistano in tal modo profonda ricchezza interiore.
Nel saggio definisce con il termine “rimozione” il fatto che il protagonista avesse “dimenticato” la profonda amicizia infantile e afferma: “…quanto è stato rimosso non può in genere imporsi senz’altro sotto forma di ricordo, ma resta capace di agire e di produrre effetti, e sotto l’influsso di qualche evento esterno può un giorno produrre conseguenze psichiche, che si possono considerare trasformazioni e derivati del ricordo dimenticato e che restano incomprensibili se non li si considera in questo modo.”
Così l’archeologo non ricorda affatto, osservando la Gradiva, di aver già visto quel particolare modo di camminare nella sua vecchia amica d’infanzia, ma è proprio da tale ricordo che deriva, senza che ne sia consapevole, la folle attrazione per tale immagine.
Freud aggiunge: “Per il momento non disponiamo di un termine migliore per designare quei processi psichici che si comportano attivamente senza tuttavia giungere alla coscienza di una determinata persona, e questo è tutto ciò che vogliamo dire con il termine inconscio.”
L’intera novella entusiasma Freud proprio perché in essa ritrova, espressi in linguaggio poetico, i concetti fondamentali della sua teoria: la vita affettiva del protagonista è descritta in corrispondenza con gli schemi interpretativi della psicoanalisi, il comportamento di Zoe è del tutto sovrapponibile all’attività di un bravo analista, i sogni del protagonista si prestano in modo particolare ad essere decifrati alla luce della sua teoria e la novella, infine, ruota attorno a Pompei, città che, sepolta dalla cenere e riemersa grazie agli scavi, risulta essere una metafora perfetta del processo della rimozione e della successiva riscoperta dei materiali inconsci grazie alla psicoanalisi.
Proprio per il suo elevato valore simbolico, Freud appese alle pareti del suo studio di Vienna una riproduzione del bassorilievo e Musatti, che ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione della psicoanalisi in Italia, ne regalò una copia a tutti gli analisti membri della Società Psicanalitica Italiana.
Gradiva è quindi, in ultima analisi, metafora della cura psicoanalitica e per questo continuamente mi ritrovo a pensarla nella mia pratica clinica, e cerco di accompagnare i pazienti nel loro viaggio di conoscenza di Sé, proprio come lei fece con il giovane archeologo tedesco.
A cura della Dott.ssa Elisa Terren
Psicologa Psicoterapeuta a Mirano e Mestre
Lettura consigliata:
Freud, S. (1906) Gradiva. Il delirio e i sogni nella “Gradiva” di Wilhelm Jensen. Biblioteca Bollati Boringhieri